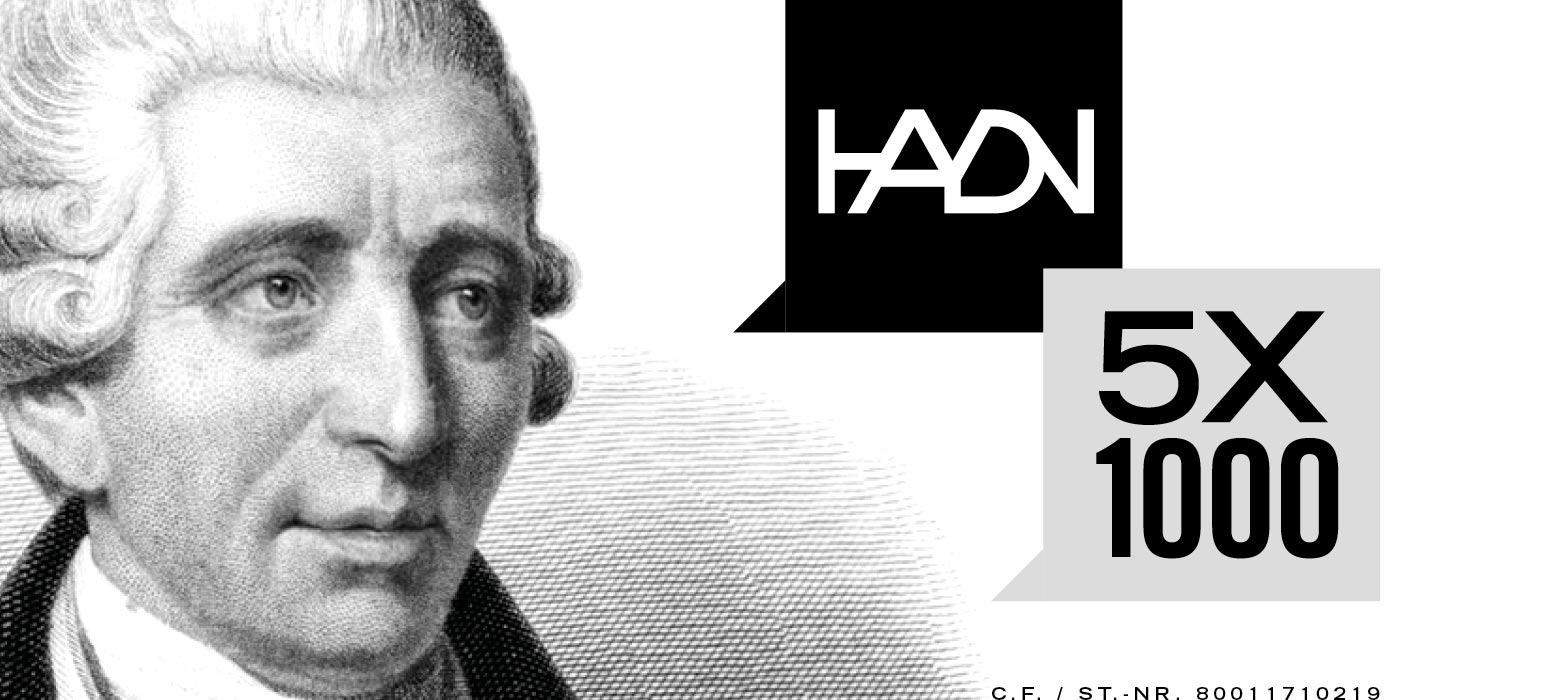I tempi, si sa, si fanno più duri – in tutti i campi. In questo scenario economico la cultura si trova ovunque a lottare per difendere il proprio spazio. Ma è anche nella sua natura non arrendersi mai e quindi, come sa essere creativa sul palcoscenico, altrettanto lo è nel trovare nuove strade per crescere. Le sfide sono molte: non si tratta solo di reperire risorse economiche, ma di costruire relazioni durature, condividere visioni, attivare comunità.
La Fondazione Haydn ha incontrato Alex Turrini, docente alla SDA Bocconi School of Management ed esperto di economia della cultura, nell’ambito della prima conferenza annuale nata dal Piano di politica culturale 2024-2034 promosso dal Comune di Trento. Un confronto che ha toccato temi chiave come il valore delle relazioni, l’importanza della progettualità e il significato profondo del “dono” nel rapporto tra istituzioni e società.
La cultura è molto più di un investimento sociale
Pubblicato
Venerdì
5 settembre 2025
Se ne parla molto oggi: la cultura può contribuire a produrre un valore economico. Quali strategie possono adottare le istituzioni culturali per far percepire questa loro forza?
Ci sono diversi strumenti. Seguendo l’esempio del Festival della Montagna e del Festival Economia si possono sviluppare degli studi di impatto economico che valorizzano la ricchezza prodotta sul territorio grazie all’esistenza di istituzioni culturali. Da una ricerca effettuata dall’Università Bocconi sappiamo, ad esempio, che per ogni euro investito nella stagione della Scala abbiamo 2,5 euro di impatto sulla città di Milano. Molto più interessanti però sono gli strumenti rendicontazione come il bilancio sociale. E per citare un caso di istituzione impegnata a quantificare il valore sociale „prodotto“ scelgo proprio la Haydn con cui abbiamo avviato un percorso di ricerca.
Nell’incontro che si è svolto a Trento ha sottolineato l’importanza di costruire delle relazioni propedeutiche al dono…ce ne può parlare?
Donare non è acquistare o vendere come se fossimo al mercato. Io faccio un regalo perché ho costruito una relazione con una persona e semplicemente per avere un grazie, essere riconosciuto ed essere più contento. Ecco: perché il dono avvenga le istituzioni culturali dovrebbero impegnarsi a costruire delle relazioni con i propri donatori, conoscerli e capire per quale motivo il donatore sentirà gioia nel donare.
Che logiche o preconcetti sarebbe utile scardinare quando parliamo di fundraising in ambito culturale? E quali elementi sono fondamentali per creare un piano di fundraising efficace?
Esiste uno stereotipo che vede il beneficio fiscale che un donatore può ottenere come la motivazione principale al donare. Tutte le ricerche in ambito filantropico ci dicono che questa non è assolutamente la motivazione principale. E d’altronde se questa lo fosse come spiegheremmo la costruzione di grandi cattedrali europee nel Medioevo grazie al crowdfunding di migliaia di cittadini e fedeli? Oppure il mecenatismo mediceo o la cappella degli Scrovegni, commissionata da Pietro per restituire alla città il maltolto del padre usuraio o, come afferma Chiara Frugoni, per lanciarsi in una carriera politico-amministrativa?
Il Trentino Alto-Adige è una realtà speciale per ragioni storiche e culturali. Quali sono gli aspetti su cui dovrebbe far leva un’istituzione culturale che desidera dialogare con il tessuto produttivo locale?
Penso sia importantissimo guardare alle necessità delle imprese e individuare quali progettualità sviluppare insieme. Senza conoscere i bisogni dell’imprenditore che, come diceva Cantillon economista dei primi del Settecento, vive nell’incertezza del proprio reddito. Ecco se le istituzioni culturali si domandassero cosa potrebbero fare per sostenere il reddito di impresa forse otterrebbero più sponsorizzazioni.
Che libro consiglierebbe a una persona che si avvicina a questi temi per la prima volta?
Per me sono stati formativi il “Saggio sul dono” di Marcel Mauss, “La grande trasformazione” di Karl Polanyi e gli scritti di Stefano Zamagni sull’economia civile. E poi c’è il mio libro* che ho scritto con due cari amici (Mark Volpe e Francesca Pecoraro) perché le cose migliori non si fanno da sole ma costruendo delle relazioni.