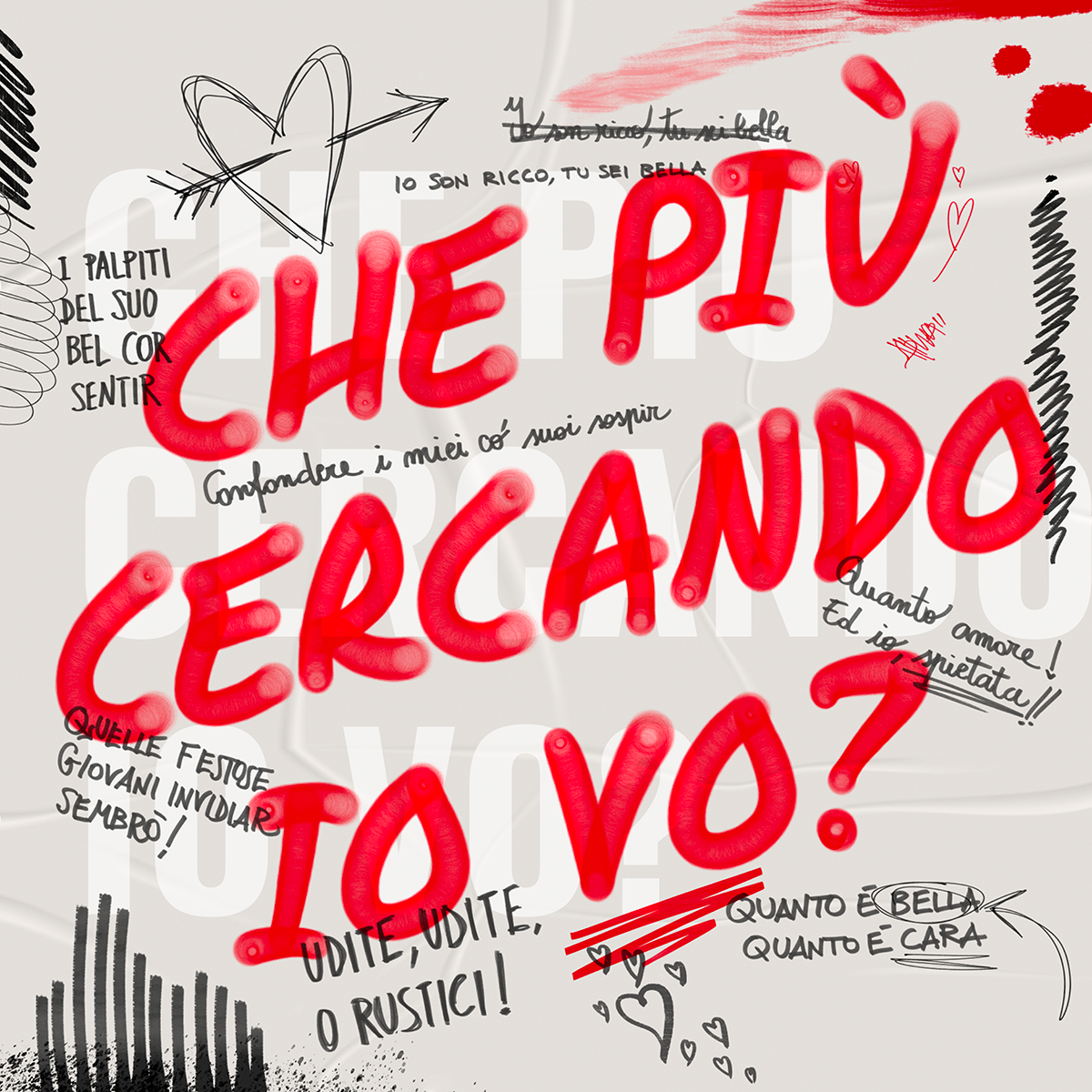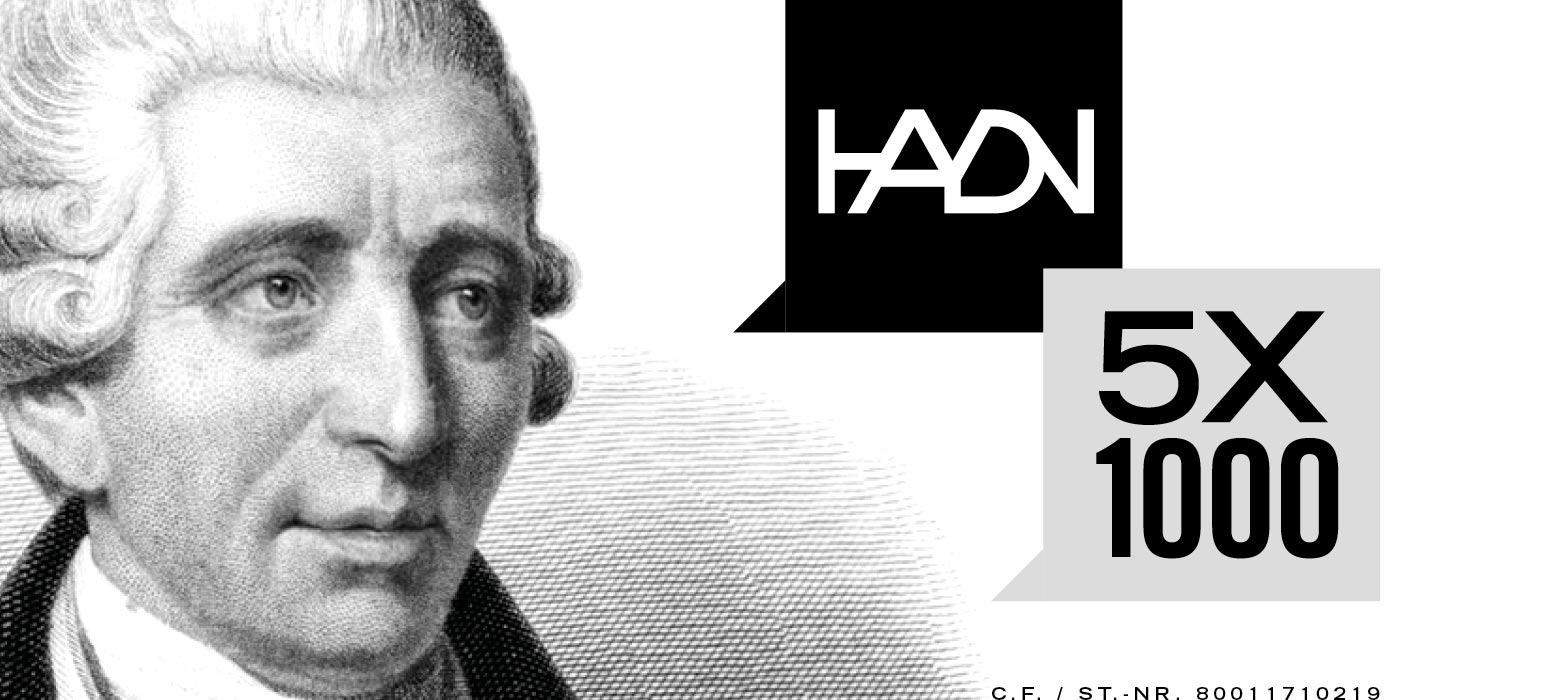L’opera è un libro vivente
Pubblicato
Martedì
28 ottobre 2025
L’opera racconta storie sempre nuove. Ne è profondamente convinto il regista Roberto Catalano, che ha messo in scena L’elisir d’amore, probabilmente l’opera più amata di Donizetti, portandola sul palco insieme all’Orchestra Haydn diretta da Alessandro Bonato.
Roberto Catalano, lei mette in scena opere da molti anni. Che cosa rende, secondo lei, il genere operistico senza tempo, quasi “immortale”?
L’opera contiene sentimenti e questi permangono sempre. La musica li fissa e li veicola amplificandoli. Credo sia per tale ragione che queste storie ci somigliano ancora oggi. Sono come certi libri “vivi” che ti parlano sempre e ogni volta in modo diverso. Quando li leggi a vent’anni provi qualcosa che non proverai quando li leggerai a quaranta. L’opera innesca in chi la vive e la ascolta lo stesso effetto. Nel suo strato più profondo si agitano sentimenti che ci parlano e ci parleranno per sempre.
Quanto contano per lei, nella messa in scena un’opera, i pensieri, gli appunti e il contesto in cui viveva il compositore — in questo caso Donizetti?
Tutti questi elementi mi influenzano, naturalmente. Per quanto il libretto resti il fondamento di ogni idea, nelle corrispondenze e negli appunti del compositore si trovano spesso degli inneschi che danno il via al processo di costruzione della drammaturgia.

Quanto, secondo lei, è già scritto nelle note di un’opera?
Le note e le indicazioni che le accompagnano tracciano la strada per restare il più possibile fedeli alle intenzioni del compositore. Ma questo non esclude le diverse interpretazioni che il libretto consente. Le parole restano le stesse, ma noi, che le leggiamo, cambiamo e cresciamo. Immobilità e fissità non appartengono all’opera. Trovo molto stimolante tornare più volte sullo stesso titolo, perché anche quando si pensa di metterlo in scena nello stesso modo, in realtà la lettura cambia ogni volta.
Si può comprendere un’opera d’arte separandola dal suo autore?
È una domanda difficilissima e non credo di avere una risposta esaustiva. Conoscere il creatore di un’opera può allargare il campo visivo sull’ opera stessa. Questo però non esclude il fatto che si possa affrontarla e goderne con occhi e orecchie vergini e privi di alcuna notizia biografica sul compositore. L’arte è a disposizione dell’umanità a prescindere da chi la crea.
Lei ha studiato filosofia ed etica. Questo influisce sul suo modo di comprendere la musica e l’opera — e, di conseguenza, sul suo lavoro di regia?
Più che aiutarmi a comprendere mi ha aiutato a pormi delle domande. La costruzione di una drammaturgia presuppone un interrogativo costante. A volte i cerchi si chiudono in fretta, altre volte no. Serve solo mettersi a disposizione della musica e delle parole scritte e tentare di indagarle con gli strumenti emotivi che si hanno a disposizione.
Sul palcoscenico lei è stato anche danzatore e mimo, e ha scritto opere proprie. Queste esperienze confluiscono anche nel suo lavoro registico?
Frequentare il palco mi aiutato moltissimo. Non avendo fatto alcuna scuola di teatro devo tutto a quell’esperienza cominciata quando avevo quattordici anni. Osservare il lavoro dei registi e ascoltare il linguaggio del palcoscenico mi ha poi dato qualche altro strumento per poter crescere e affrontare il mio lavoro.
La sua nuova regia de “L’elisir d’amore” a Bolzano si apre con un flashback – e in generale è attraversata da diversi salti temporali…
All’inizio c’è una bambina che viene spinta giù da un’altalena. A tradirla con questo gesto poco gentile è un bambino di cui lei si fidava. La bambina è Adina e da quel momento, ogni sua relazione sarà segnata della paura di essere tradita ancora una volta.

“L’elisir d’amore” è tra i melodrammi più celebri e amati, e l’aria “Una furtiva lagrima” è diventata una sorta di “inno”. È una benedizione o una malediazione?
L’aria in questione crea certamente attesa e un’alta aspettativa. Non so dire se questa sia una benedizione o una maledizione, un peso o una fortuna. Credo però che finché ci sarà attesa e aspettativa per qualcosa che appartiene al patrimonio di tutti ci sarà speranza.
Un’ultima domanda: in un progetto operistico, quale fase aspetta con più entusiasmo – le prove, la prima o l’incontro con il pubblico?
Tutte e tre! Ma ne aggiungerei una quarta: la fase creativa. Quella dove si cerca il cortocircuito che darà il via al movimento che porterà alla costruzione della drammaturgia. Quella dove si lavora in squadra per trovare il mondo che verrà poi abitato dagli interpreti. Per quanto oggi i tempi di elaborazione di un progetto si siano molto accorciati, questa resta la fase più “lenta” della lavorazione di uno spettacolo. E oggi la lentezza è la cosa più preziosa che possiamo concederci.